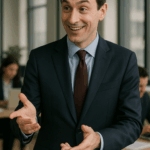Se ami l’azienda, resta oltre l’orario: il ricatto emotivo che uccide la vita
C’è una bugia sottile che si infiltra tra le scrivanie, i badge e i fogli Excel. È il messaggio non detto, ma costante, che chi davvero tiene all’azienda lo dimostra restando oltre l’orario, rinunciando al pranzo, rispondendo alle mail la sera tardi o nei weekend. È il veleno dell’apparenza: “Chi ama, si sacrifica”. Ma cosa stiamo davvero amando? Stiamo praticando il culto dello straordinario?
Molti lavoratori, ogni giorno, si trovano a fare i conti con una cultura aziendale che ha travisato il concetto di dedizione, trasformandolo in sottomissione. Si insinua nei corridoi l’idea che il valore di una persona si misuri in minuti trattenuti in più, nonostante nessuno li chieda formalmente, ma tutti li notano. “Hai recuperato il ritardo di stamattina? Bravo. Ma forse potresti fermarti ancora un po’, no?”. quasi come se fosse di moda il culto dello straordinario.
Questa realtà tossica si nutre del silenzio e dell’invisibilità. Se rifiuti lo straordinario non retribuito, se chiedi di rispettare i confini del contratto, se ricordi che hai anche una famiglia, un figlio, una vita – rischi l’etichetta di “poco motivato”. Come se l’unica forma di passione lecita fosse quella diretta all’impresa.
L’inganno del “famiglia aziendale” ed il culto dello straordinario
“Qui siamo come una famiglia.” Quante volte si sente questa frase nei colloqui, nelle riunioni, nei discorsi dei dirigenti? Eppure, una vera famiglia non ti fa sentire in colpa per essere umano. Non ti misura a cronometro. Non ti chiede prove d’amore ogni giorno per meritarti un posto al tavolo.
In realtà, molte aziende usano l’idea della “famiglia” come una coperta calda per coprire il freddo della performance. Il risultato è un ambiente dove ci si sente obbligati a dimostrare riconoscenza continua, come se lo stipendio ricevuto fosse un favore, non un diritto.
La verità è che in questi contesti si assiste a una spersonalizzazione profonda. Il lavoratore non è più visto come essere umano, ma come componente. E come ogni ingranaggio, è valutato sulla base di quanto resiste, quanto gira, quanto produce. Nessuno si chiede se è felice. Nessuno si chiede se sta bene.
Il prezzo dell’orgoglio malato
“Dovresti rimanere di più per orgoglio.” Anche questa frase la sentiamo, magari detta con tono amichevole, oppure sibilata dietro una porta chiusa. Ma che tipo di orgoglio è quello che ci allontana dai nostri cari? Che ci fa sentire in colpa per avere una vita?
Il lavoro nobilita, sì. Ma non può divorare. La dedizione ha un valore solo se è scelta libera, non se è estorta attraverso il ricatto morale. Eppure, in tante aziende il confine tra impegno e sfruttamento viene cancellato con una gomma invisibile ma potente: quella della “cultura aziendale”. Secondo Christina Maslach, una delle massime esperte mondiali di burnout, il problema non è il lavoratore che “non regge”, ma l’ambiente che diventa emotivamente esigente senza offrire alcun sostegno reale. È un modello economico e relazionale che pretende lealtà unilaterale. Un amore a senso unico, dove se ti fermi, vieni sostituito.
Ma noi non siamo macchine
Erich Fromm, nel suo “Avere o Essere?”, ci ricordava che una società sana è quella che mette l’essere prima dell’avere. Eppure, nelle imprese moderne l’identità delle persone viene spesso ridotta a quanto “offrono” in termini di tempo, obbedienza e flessibilità. Ma noi non siamo il nostro badge, il nostro orario, il nostro report. Siamo padri, madri, figli, amanti, amici. Siamo vite che chiedono spazi di significato. Una vita piena non si misura in KPI, ma in connessioni profonde. Non nei minuti di straordinario, ma nei secondi vissuti con intensità. Un figlio che ride, una cena condivisa, un pomeriggio di sole. Il lavoro deve avere il suo spazio, non il trono.
Il rischio della complicità
Chi accetta questo gioco e lo perpetua, finisce per diventare complice. Non solo i datori di lavoro, ma anche i colleghi che giudicano, i capi intermedi che replicano i modelli appresi, i collaboratori che guardano con sospetto chi timbra “in orario”. Ma a che serve essere l’ultimo a uscire dall’ufficio se si è i primi a dimenticare se stessi?
Il vero cambiamento non passa solo per le policy aziendali, ma per una rivoluzione culturale. Serve un nuovo vocabolario: “efficienza” non può significare rinuncia, “produttività” non può voler dire assenza, “passione” non può coincidere con annullamento.
Una nuova etica del lavoro
La dignità del lavoro non si misura sulla quantità di tempo che si sacrifica, ma sulla qualità della vita che si riesce a costruire anche grazie ad esso. Dovremmo tornare a un’etica in cui il lavoro è parte della vita, non il contrario. Come scrivevo in una mia riflessione: “Se il lavoro ti chiede di dimenticarti chi sei, non è il tuo lavoro. È una gabbia con il logo aziendale stampato sopra.” – Giacomo Lastretti
Il futuro sarà di chi saprà unire risultati e umanità. Di chi costruirà imprese sane, dove si lavora bene e si vive meglio. Perché il benessere non è un benefit. È un diritto.
Bibliografia:
-
Maslach, C., & Leiter, M. P. (1997). The Truth About Burnout. Jossey-Bass.
-
Fromm, E. (1976). Avere o Essere?. Mondadori.
-
Sennett, R. (1998). L’uomo flessibile. Feltrinelli.
-
Rifkin, J. (2000). La fine del lavoro. Baldini & Castoldi.