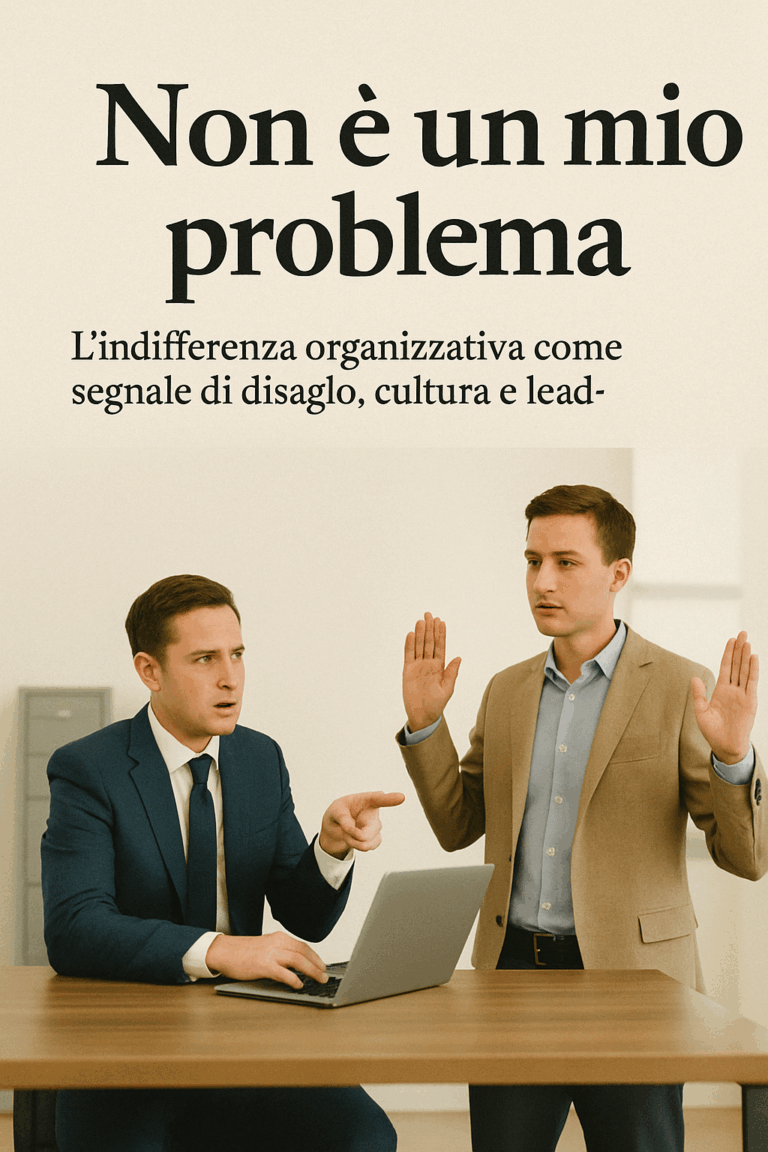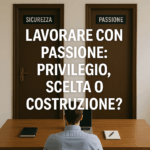L’indifferenza organizzativa come segnale di disagio, cultura e leadership
“Ogni volta che diciamo ‘non è un mio problema’, costruiamo un muro invisibile tra noi e la possibilità di fare la differenza.” — Giacomo Lastretti
Nel cuore di molte dinamiche aziendali si nasconde una frase che apparentemente sembra solo una difesa o un confine: “Non è un mio problema”. È una risposta che può arrivare secca, lapidaria, detta a denti stretti o con noncuranza. Ma dietro queste cinque parole si nasconde molto più di un semplice rifiuto: c’è cultura, c’è psicologia, c’è spesso dolore.
Chi pronuncia questa frase – sia esso un dirigente o un dipendente – sta comunicando qualcosa che va ben oltre il contenuto apparente. Sta dicendo, in fondo: “Non voglio occuparmene. Non mi riguarda. Non ne valgo la pena. Non mi pagano per questo. Non ci tengo abbastanza.”
Il meccanismo psicologico: protezione o cinismo?
Secondo lo psicologo sociale Albert Bandura, le persone sviluppano strategie di “disimpegno morale” per non sentirsi colpevoli nel rifiutare aiuto o coinvolgimento. Dire “non è un mio problema” può diventare una forma di auto-assoluzione. È un modo per evitare conflitti, risparmiare energie, proteggersi da una responsabilità emotiva. Ma quando il disimpegno diventa sistemico, si trasforma in cinismo organizzativo.
Chi risponde così, spesso, è stanco. O peggio: è disilluso. Magari ha visto troppi sforzi non riconosciuti o ha interiorizzato una cultura aziendale in cui l’“ognuno per sé” è diventato la regola non scritta. In questo caso, la frase è un sintomo più che un errore.
Non è un mio problema, quando a dirlo è un dirigente
Se è un capo a pronunciare “non è un mio problema”, le conseguenze sono più gravi. Perché il dirigente, per sua stessa definizione è il garante dell’insieme. Un leader che taglia corto con questa frase, anche solo una volta, invia un messaggio potente: “sei solo”. Il “non è un mio problema” pronunciato in cima alla gerarchia è un veleno che scende a cascata e autorizza tutti a fare lo stesso.
Come sottolineava Daniel Goleman, l’intelligenza emotiva nei leader si misura anche (e soprattutto) nella capacità di farsi carico, di mostrare presenza, non solo competenza. Un capo che si disimpegna, può ottenere rispetto per la sua freddezza, ma mai fiducia per la sua umanità.
Quando a dirlo è un sottoposto
Capovolgiamo il punto di vista. Immaginiamo un dirigente che delega un’attività, o segnala un’urgenza, e riceve in risposta: “Non è un mio problema”. Qui entriamo in un territorio altrettanto delicato. È una forma di sabotaggio silenzioso. È un modo per dire: “non ti riconosco come guida, non sento questa azienda come mia, non mi fido di te.”
Può essere una risposta carica di rancore, di ritorsione passiva, di demotivazione. Oppure può essere anche un grido implicito: “nessuno mi ha mai ascoltato prima, perché dovrei ascoltare adesso?”
Come scrive Amy Edmondson nel suo lavoro sulla sicurezza psicologica, “le persone tacciono o si tirano indietro quando percepiscono che parlare o agire ha un costo maggiore che restare in silenzio”. In questo senso, il “non è un mio problema” è un segnale che dovrebbe sempre farci fermare e indagare.
Una cultura del “noi” va costruita, non richiesta
È troppo facile giudicare chi pronuncia questa frase. È più utile capire cosa l’ha generata. In molte aziende si parla di “spirito di squadra”, ma si premiano solo i risultati individuali. Si chiede collaborazione, ma si penalizza l’errore. Si invoca responsabilità diffusa, ma si attribuiscono colpe verticali.
Il risultato? Ognuno si difende. Ognuno costruisce confini e la frase “non è un mio problema” diventa la bandiera dell’autodifesa professionale.
Le conseguenze di lungo periodo
A forza di sentirla, quella frase crea solchi invisibili, si rompe la fiducia nei team, si rallenta il flusso operativo, si inaridisce l’empatia aziendale, si abbassa il senso di appartenenza e si moltiplicano i problemi… perché nessuno li sente suoi. Un’azienda dove tutto “non è mai problema di nessuno” è un luogo dove i problemi, semplicemente, marciscono.
Come affrontare la cultura del disimpegno
Per contrastare questa deriva, servono gesti concreti:
-
Chiarire le responsabilità ma anche i confini, senza lasciare zone grigie.
-
Premiare l’iniziativa anche fuori dal perimetro ufficiale.
-
Allenare l’empatia professionale: riconoscere il valore dell’altro.
-
Agire come esempio, a ogni livello.
-
Offrire luoghi di ascolto, coaching e confronto.
Perché quando qualcuno dice “non è un mio problema”, ha già smesso di sentire che la sua presenza faccia la differenza. E questo, sì caro lettore, è un problema di tutti.
Bibliografia:
-
Goleman, D. (1998). Intelligenza emotiva. Rizzoli.
-
Bandura, A. (1991). Social cognitive theory of moral thought and action. In W. Kurtines & J. Gewirtz (Eds.), Handbook of moral behavior and development.
-
Edmondson, A. (2019). The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth. Wiley.
-
Bauman, Z. (2000). Liquid Modernity. Polity Press.
-
Sennett, R. (1998). L’uomo flessibile. Feltrinelli.