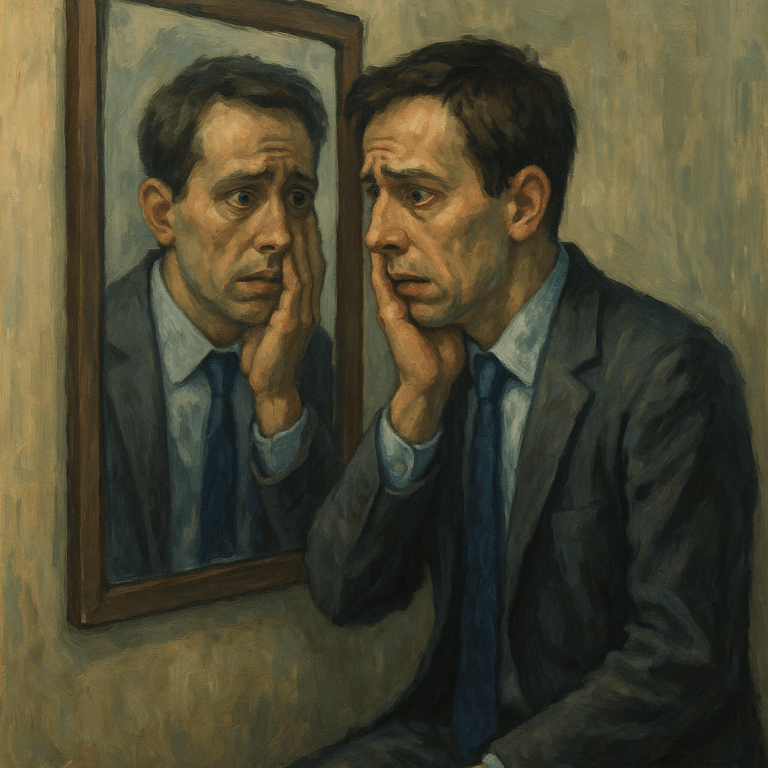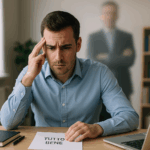Quella stretta allo stomaco prima del lavoro: una paura silenziosa della quotidiana ansia lavorativa
Ci sono mattine in cui la sveglia non suona soltanto. Ulula. Lo stomaco si stringe, la mente corre veloce immaginando scenari spiacevoli: un rimprovero ingiusto, un collega ostile, un cliente che alza la voce, un capo che ignora o schiaccia. È una paura silenziosa, spesso taciuta anche a se stessi. Ma è reale.
Quella sensazione che precede il lavoro non è solo ansia passeggera: per molti è una costante, una compagnia invisibile che si presenta ogni sera prima di dormire e ogni mattina appena ci si alza. Un nodo, una pressione, una paura.
Il lavoro come teatro dell’ansia
Nel nostro immaginario collettivo, il lavoro dovrebbe essere un luogo di realizzazione, autonomia, crescita. Ma troppo spesso si trasforma in un campo minato emotivo. I numeri lo confermano: secondo un’indagine dell’EU-OSHA (2023), oltre il 25% dei lavoratori europei riferisce sintomi di stress legati all’ambiente di lavoro, e l’ansia è tra i disturbi più comuni. Ma cosa genera questa paura? Non si tratta solo della mole di compiti o delle responsabilità. Le vere spine, spesso, sono relazionali:
-
Il capo autoritario o instabile, che comunica attraverso l’ambiguità o il silenzio;
-
Il collega competitivo, che minaccia passivamente con il suo comportamento;
-
Il pubblico esigente, fonte di giudizio costante, soprattutto per chi lavora a contatto diretto con i clienti.
A ciò si aggiunge la paura di sbagliare, di deludere, di non essere all’altezza. È una paura sottile, ma cronica. E quando si cronicizza, diventa tossica.
La paura come segnale (non come colpa)
In psicologia, la paura è un’emozione primaria, utile, un campanello di allarme che ci segnala un potenziale pericolo. Non va negata né combattuta con frasi da slogan. Va ascoltata. Quando la paura di andare a lavoro prende il sopravvento, sta comunicando qualcosa di importante. Magari ci troviamo in un contesto non adatto, in un ruolo che non ci rappresenta, in una cultura aziendale disfunzionale. L’errore è pensare di essere noi il problema. Come spiega il professor Gino Mazzoli, esperto di dinamiche organizzative: “Quando un’organizzazione produce disagio sistemico, il disagio non è del singolo, è il contesto che va messo in discussione.” In altre parole: non sei tu ad essere fragile, forse è l’ambiente ad essere nocivo.
Le forme più comuni di ansia lavorativa
Ci sono diverse forme con cui la paura lavorativa si manifesta:
-
La sindrome del lunedì – Un classico. L’idea di dover tornare in ufficio genera un’angoscia anticipatoria;
-
L’ansia da performance – Chi ha lavori esposti (venditori, insegnanti, infermieri) teme il giudizio costante;
-
L’ansia relazionale – Timore di scontri o conversazioni difficili con colleghi o capi;
-
La paura dell’errore – Il perfezionismo patologico porta a uno stato d’allerta cronico;
E quando questa ansia si ripete ogni giorno, il corpo inizia a pagarne il conto: mal di testa, stanchezza cronica, insonnia, problemi gastrointestinali. La mente, invece, inizia a spegnersi: meno creatività, meno motivazione, meno lucidità.
Perché è così difficile parlarne?
La risposta è semplice: vergogna. Viviamo in una cultura del “tieni duro”, “non ti lamentare”, “sei fortunato ad avere un lavoro”. Questo porta le persone a silenziarsi, a sentirsi deboli se ammettono di avere paura. Ma la paura non è un segno di debolezza: è un segno di consapevolezza. Come scrive Brené Brown, studiosa della vulnerabilità: “La vulnerabilità è il coraggio di essere presenti, anche quando la paura ci dice di fuggire.”
Uscire dal silenzio: il primo passo
Il primo passo per affrontare questa paura è nominarla. Dirla ad alta voce, a sé stessi e, quando possibile, a qualcuno di fiducia. Un collega, un amico, un coach. Rendersi conto che non si è soli cambia radicalmente la percezione del problema. Poi viene il lavoro interiore: comprendere le dinamiche che ci spaventano, imparare a gestire il confronto, sviluppare assertività e mettere dei confini. Infine, se il contesto non cambia, valutare seriamente l’opportunità di cambiare contesto.
Il ruolo del coaching
In molti casi, affidarsi a un professionista esterno può fare la differenza. Un coach specializzato nei rapporti sul lavoro può aiutarti ad analizzare le paure, riconoscere le dinamiche tossiche, riprendere in mano il proprio potere decisionale. Soprattutto, fornisce uno spazio sicuro dove parlare, riflettere, costruire strategie concrete. Nel mio lavoro, ho incontrato persone brillanti che si sentivano spezzate. Non erano rotte. Erano semplicemente in ambienti che le spegnevano. E quando hanno iniziato a riappropriarsi della loro voce, della loro presenza, tutto è cambiato. La paura non va tolta. Va attraversata.
Conclusione
Andare a lavoro non deve far paura. Non ogni giorno, almeno. Quando la paura diventa la norma, è tempo di fermarsi, ascoltarla e agire. Non c’è nulla di debole nel dire: “Così non sto bene”. C’è anzi, una forza rara. Quella di chi ha deciso di tornare protagonista della propria storia.
Bibliografia e fonti
-
EU-OSHA (2023). European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks;
-
Gino Mazzoli, Organizzazioni che curano. Il valore delle relazioni nei luoghi di lavoro, Erickson, 2019;
-
Brené Brown, La forza della fragilità, Vallardi, 2021;
-
American Psychological Association (APA), Workplace Stress Statistics, 2022;
-
Judith S. Beck, Cognitive Therapy: Basics and Beyond, 2011.