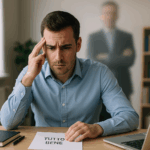Lo smart working oggi
Sembra passato un secolo da quando, nella primavera del 2020, milioni di lavoratori hanno chiuso le porte dei loro uffici per aprire quelle di casa. Zoom, Teams, VPN, hot spot: parole diventate pane quotidiano per chi si è trovato – spesso da un giorno all’altro – a lavorare in tuta, con una tazza di caffè accanto al portatile, e il gatto che si faceva largo tra le call. Ma lo smart working, a ben vedere, non è nato con la pandemia. È figlio di una visione più antica, più lenta, più rivoluzionaria di quanto sembri. Una visione che oggi, nel 2025, rischia però di smarrirsi tra nostalgia del “controllo in presenza” e ansia da produttività.

Le radici: il telelavoro prima dello smart
Il primo seme dello smart working fu il telelavoro, un termine comparso negli anni ’70, quando il fisico Jack Nilles parlava di “telecommuting” per ridurre il traffico a Los Angeles. Il telelavoro, nella sua accezione storica, si limitava a un semplice concetto: lavorare da remoto, ovvero eseguire le stesse mansioni da casa anziché dall’ufficio. Nessuna autonomia, pochi strumenti, molti vincoli. Solo negli anni 2000, con l’avvento delle tecnologie digitali e delle piattaforme collaborative, cominciamo a parlare di lavoro agile, tradotto in Italia come “smart working” – una definizione che purtroppo ha portato con sé un’ambiguità lessicale: non significa “lavorare da casa”, bensì lavorare in modo intelligente, per obiettivi, con flessibilità di tempi, luoghi e modalità. Lo smart working, in teoria, è cultura organizzativa prima che modalità operativa. È responsabilità condivisa, è fiducia, è libertà. Ma in pratica?
Lo shock pandemico e il boom dello smart working
Nel 2019, in Italia solo il 4,8% dei lavoratori utilizzava modalità di lavoro agile. Nel 2020, si è passati al 33% durante i mesi più duri del lockdown. Parliamo di circa 6,5 milioni di persone. Uno shock organizzativo che ha costretto aziende pubbliche e private ad accelerare un cambiamento previsto in 10 anni. Quello che è avvenuto, però, non è stato del tutto smart working, bensì “remote working d’emergenza”. Non era progettato, non era negoziato, non era sostenuto da policy aziendali né da formazione ad hoc. Era una reazione. Ma la reazione ha funzionato. Secondo il Politecnico di Milano (Osservatorio Smart Working), il 71% dei lavoratori ha dichiarato un aumento della produttività nei primi sei mesi del 2020, e molte aziende hanno scoperto che potevano ottenere gli stessi risultati… senza spese d’ufficio, senza spostamenti, con maggiore soddisfazione dei dipendenti. Eppure, finita l’emergenza, si è tornati (in parte) indietro.
Smart working nel 2025: i numeri (e i paradossi). Dove siamo oggi? Secondo i dati dell’INAPP e dell’Osservatorio del Polimi (2024-2025):
-Solo il 14% dei lavoratori italiani è attualmente in modalità smart working stabile;
-La percentuale sale al 34% nel settore privato, ma crolla al 7% nella pubblica amministrazione;
-Le grandi imprese (oltre 250 dipendenti) sono le più attive: quasi il 50% ha strutturato programmi di smart working;
-Le micro e piccole imprese restano ancora ancorate a logiche tradizionali;
E il paradosso è evidente: l’Italia è uno dei paesi con la più bassa adozione strutturale dello smart working in Europa, nonostante la sperimentazione forzata della pandemia. Colpa della cultura del controllo, della mancanza di formazione manageriale sulla leadership a distanza, e dell’assenza di una politica pubblica coerente.
I vantaggi (scientificamente provati) La letteratura scientifica è unanime nel riconoscere numerosi benefici dello smart working ben progettato:
-Maggior benessere psicologico: meno stress da pendolarismo, più autonomia (Eurofound & ILO, 2017).
-Maggiore produttività, fino al +13% secondo uno studio di Bloom et al. (2021).
-Minor turnover: il senso di fiducia migliora l’engagement e la retention.
-Riduzione dell’impatto ambientale: meno spostamenti, meno emissioni.
-Inclusione: più opportunità per caregiver, persone con disabilità o residenti in zone periferiche.
Ma ci sono anche effetti collaterali se mal gestito: isolamento sociale, sovrapposizione tra vita privata e lavoro, precarizzazione, burnout da iperconnessione.
Dove andiamo?
La sfida ora non è “tornare in ufficio o restare a casa”, ma costruire un vero paradigma ibrido, in cui le persone siano formate, ascoltate, responsabilizzate. In cui si lavori per obiettivi e non per orari, dove il controllo venga sostituito dalla fiducia, e la presenza in sede diventi un momento di connessione e non di burocrazia. Serve una leadership nuova, capace di gestire team a distanza, di comunicare in modo chiaro, di usare strumenti digitali con consapevolezza. Serve un’educazione al lavoro che parta già dalle scuole e dall’università. Serve, infine, un contratto culturale nuovo tra azienda e lavoratore. Come dice la professoressa Chiara Succi della SDA Bocconi: “Lo smart working non è un benefit, è un cambio di paradigma. Ma come ogni cambiamento, va accompagnato. Altrimenti diventa un boomerang.”
Conclusioni
Lo smart working non è una moda, né un privilegio. È un’opportunità – ancora largamente sprecata – per lavorare meglio, non di più. Ma senza una visione culturale e strategica condivisa, resterà solo un esperimento legato alla pandemia. Il futuro del lavoro non sarà tutto da casa, ma nemmeno tutto in ufficio. Sarà flessibile, intelligente e soprattutto umano, se sapremo progettarlo insieme.
Bibliografia
- Osservatorio Smart Working, Politecnico di Milano (2023-2025);
- INAPP – Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (2024);
- Eurofound & ILO (2017), Working anytime, anywhere: The effects on the world of work;
- Bloom, N. et al. (2021), Does Working from Home Work? Evidence from a Chinese Experiment, Stanford University;
- Succi, C. (2022), Il futuro del lavoro è ibrido, SDA Bocconi Insight.